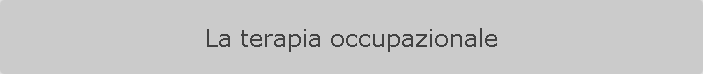
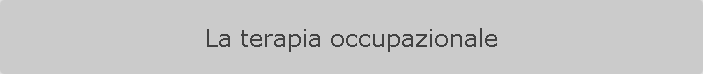
tratto dalla
TESI DI Silvia Maria Vizio:
"LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA IN CASA DI RIPOSO ATTRAVERSO L'INTERVENTO ANIMATIVO:UNA STRATEGIA COMPLESSA"
- CORSO DI QUALIFICA ANIMATORE SOCIALE -
ENAIP LOMBARDIA - ANNO 1998
Questa tecnica di lavoro, come sostiene la definizione di Spackman, si occupa
delle attività umane, e utilizza l'applicazione di normali mansioni di vita, o
trattamenti specifici, oppure, ancora, usufruisce di una simulazione di attività
lavorativa. Il concetto basilare è che una persona, stimolando l'uso delle mani,
che sono governate dalla mente e dalla volontà, riesce ad influire sul proprio
stato mentale. Ognuno di noi può normalmente constatare come "lavorare" non
significhi necessariamente guadagnarsi da vivere: è nella natura stessa
dell'essere umano impiegare il proprio tempo in diverse attività, che
coinvolgono i sensi, ma anche la sfera affettiva, sociale e così via.
L'attività in senso terapeutico si rivolge, in particolare, ai deficit
sensoriali, percettivo-motori, cognitivi e comportamentali: se applicata nei
confronti dell'anziano, si dimostra molto utile, poiché considera la persona nel
suo insieme e non si riduce all'applicazione fisica di una terapia. In questo
senso, è assai consona al modus operandi dell'educatore - animatore, visto che
l'intervento prevede una valutazione generale dell'individuo, delle sue abilità
e interessi, al fine di dare un valore alla sua vita e stimolare le sue
originali capacità, in modo da mantenerlo nelle sue funzioni umane e sociali.
Quando una persona anziana entra in istituto, spesso compie questo passo non per
propria libera decisione, ma per cause di forza maggiore: ciò porta a problemi
di ambientamento, traumi e, addirittura, ad un ulteriore aggravamento.
King e Raynes hanno individuato alcuni fattori che, nell'istituzionalizzazione,
portano l'anziano a perdere la propria identità:
Depersonalizzazione, causata dalla perdita di privacy e dall'impossibilità di avere effetti personali.
Distanza sociale, dovuta al distacco tra l'ospite e il personale.
Trattamento in blocco; l'anziano non subisce trattamenti personalizzati, ma deve sottostare alle esigenze dell'organizzazione, indipendentemente dalle sue reali necessità.
Mancanza di valutazione della routine quotidiana: i giorni si susseguono tutti uguali.
Da tutto questo, proviene la condizione di disagio che
l'anziano è costretto a vivere, con conseguente depressione, solitudine,
disistima, eccetera. Le sue problematiche, all'opposto, necessiterebbero di
un'assistenza assidua, completa e competente e di una situazione che non sia
fonte di ulteriore disagio. Si è notato che, spesso, gli ambienti in cui vivono
gli anziani danno scarse stimolazioni sensoriali: a causa di ciò, la persona può
attuare una deprivazione volontaria e decidere di respingere ulteriori stimoli.
Cesa Bianchi spiega la deprivazione sensoriale come "condizione in cui
un soggetto si trova isolato dalla consueta realtà ambientale per l'assenza o la
riduzione degli stimoli esterni", e ne identifica diverse tipologie:
Deprivazione sensoriale propriamente detta, in cui la riduzione della stimolazione è puramente quantitativa, come nella cecità, la sordità, ecc.
Deprivazione percettiva. In questo caso si ha un'alterazione quali-tativa della stimolazione, tanto che le informazioni sensoriali risultano distorte.
Deprivazione sociale: il soggetto è isolato da ogni
contatto interpersonale.
Questi tre aspetti della deprivazione possono essere anche
definiti come effetti da ipostimolazione, e sono spesso interdipendenti. Il
primo intervento da attuare è correggere il più possibile i deficit sensoriali:
per esempio, nel caso di difficoltà visive, si devono informare tutti coloro che
entrano in contatto con l'anziano, sulla distanza da tenere per permettergli di
vedere persone e oggetti; se la persona è sorda si possono utilizzare immagini o
scrivere le parole.
Per chiarire il ruolo della terapia occupazionale nel trattamento dei disagi
suddetti, Bianca Petrucci, in una sua trattazione, riporta alcuni esempi di
esperienze pratiche effettuate da studiosi inglesi e americani. Nel 1958, Casin
applicò, ad un gruppo di dementi senili, attività di terapia occupazionale,
sociali e domestiche, con lo scopo di ottenere comportamenti appropriati e di
migliorare la qualità di vita. Egli, nel tempo, verificò che diminuì
l'aggressività e migliorarono il ritmo sonno-veglia e il comportamento sociale.
In Australia, nel 1967, Bower fece un'esperienza simile con 25 donne affette da
demenza senile: egli suddivise il trattamento in sedute di quattro ore e mezza
giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per un periodo di sei mesi.
Anche in questo caso, furono notati significativi miglioramenti nei rapporti
sociali e nella quotidianità. Loew e Silverstone, nel 1971, stimolarono
fisicamente, socialmente e psicologicamente un gruppo di 14 uomini anziani, che
sviluppò e mantenne nel tempo l'attenzione e la memoria presente. Infine, Salter
e Salter usarono un trattamento più completo delle attività della vita
quotidiana, tramite attività creative, ricreative e di orientamento alla realtà
per circa quattro mesi, ottenendo numerose e specifiche trasformazioni positive:
migliorarono l'attenzione, la memoria presente e la capacità di riconoscimento
di alcuni oggetti della vita quotidiana, tanto da riacquisire una certa
autosufficienza.
Nella pratica, la terapia occupazionale è attuata secondo lo schema seguente:
1) E' indispensabile una valutazione iniziale dello stato della persona anziana,
tramite, (per esempio, la scala Mini Mental State), allo scopo di selezionare
alcuni gruppi di lavoro e determinare le modalità e i fini specifici
dell'intervento. A una valutazione dello stato mentale, va aggiunta una
considerazione sulla vita sociale dell'ospite e la misurazione delle sue
capacità residue di autosufficienza. Naturalmente, non si può prescindere
dall'effettuare il profilo degli interessi personali e delle esperienze passate.
2) La realizzazione della terapia occupazionale si esplica, poi, nella
realizzazione delle motivazioni seguenti: fare in modo che l'anziano non
consideri terminata la propria esistenza e desideri essere coinvolto.
3) Ciò si realizza tramite la mobilizzazione, in modo che l'ospite recuperi una
certa autonomia, rinforzando le capacità fisiche residue.
Occorre, inoltre, sviluppare l'indipendenza nelle normali attività quotidiane,
incoraggiare la socializzazione con gli operatori e gli altri anziani;
riorientare alla realtà; migliorare la qualità della vita, creando un ambiente
confortevole, sicuro e familiare; mantenere le abilità fisiche e mentali. Queste
caratteristiche possono essere facilmente ricondotte ai principi basilari
dell'animazione, e denotano, perciò, alcune linee guida tipiche
dell'impostazione del lavoro.